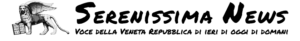“Il ruggito di Hampden. Storia culturale della tifoseria scozzese dai Wembley Warriors alla Tartan Army” è un libro di Mauro Bonvicini per Eclettica Edizioni, che illumina il carattere identitario del tifo calcistico, che sa essere espressione delle “nazioni senza Stato” e della più autentica anima di un popolo.

Serenissima News pubblica qui l’introduzione dell’Autore, instancabile animatore del Centro Studi “Millecentoventi” di Spilimbergo (Pn), un gruppo culturale che promuove la ricerca, in particolare su temi di identità e tradizione, e già in libreria con “Irregolari. Sottoculture di strada e di stadio tra Europa e Nord America 1870-1914” e “Glasgow belongs to me. Ode ad una città dopo un paio di pinte” scritto a quattro mani con Francesco Basso.
La Nazionale scozzese
Il mondo calcistico italiano nutre da tempo un interesse particolare per la Scozia e il suo football nonostante la presenza nel nostro campionato di giocatori provenienti da nord del Vallo di Adriano sia sempre stata alquanto risicata.

Le esperienze maturate nella Penisola da alcuni di essi, ad esempio Denis Law e Joe Jordan, e la trasmissione anche nelle nostre case dei Mondiali degli anni Settanta e Ottanta ai quali la Nazionale scozzese ha partecipato, hanno fatto sì che si vedesse negli atleti provenienti da quelle latitudini un esempio di ardore e tenacia particolarmente apprezzato dai tifosi.
Una squadra, una Nazione
Momenti a loro modo storici, come il goal di Gemmill ad Argentina ‘78 o quello di Narey contro il Brasile a Spagna ’82, sono stati poi essenziali per far scoprire l’esistenza di una squadra e di una Nazione che, pur provenendo da un contesto tutto sommato simile, erano capaci di differenziarsi in maniera evidente da un’Inghilterra non di rado guardata con un certo sospetto.

È però con la presenza massiccia, calorosa e colorata calata su Genova e Torino al seguito della Nazionale di Andy Roxburgh in occasione di Italia ’90 che scatta nei cuori di molti sportivi la scintilla di una passione che da subito si sviluppa su un binario assolutamente peculiare: complici gli onestamente prescindibili risultati ottenuti sul campo, al centro dell’interesse di molti non c’è tanto la squadra quanto piuttosto la sua tifoseria.
Tifo per la Scozia
I fortunati abitanti delle due città hanno infatti modo di scoprire che questi ospiti tutt’altro che indesiderati sono contraddistinti da un atteggiamento platealmente aperto e goliardico e si innamorano perdutamente del clima festoso che li circonda ovunque vadano.
La simpatia reciproca che si instaura nel corso della permanenza trascende da subito il semplice tifo sportivo (che pure non manca visto che soprattutto a Marassi il pubblico italiano si schiera compattamente a favore della Scozia) e consente persino di sorvolare su alcuni eccessi, come le docce improvvisate nelle fontane di piazza De Ferrari, che – anzi – vengono visti come divertenti bizzarrie grazie all’assoluta buona fede dei protagonisti.
La trasferta di San Marino
Nei bar e nelle trattorie del centro storico gli Scozzesi ricevono sempre un caldo benvenuto cementando così una relazione talmente forte da restare viva anche una volta esauritosi il Mondiale, come testimonia la spedizione di alcuni reduci dalla trasferta di San Marino del maggio 1991 che prolungano intenzionalmente il soggiorno pur di visitare nuovamente il capoluogo ligure.
Qui, manco a dirlo, vengono accolti come celebrità dagli avventori dei vari locali in cui si avventurano con tanto di Flower of Scotland intonato in loro onore. Nemmeno chi vive nel resto del Paese rimane immune da questa fascinazione perché i reportage di stampa e telegiornali non si lasciano sfuggire l’occasione di illustrare una versione del “modello britannico” inaspettata e rassicurante dopo le generalizzazioni seguite alla tragedia dell’Heysel.
La tartan craze
In particolare lo spettacolo di tifo e sincera passione o scoperto al Ferraris prima, durante e dopo la partita con la Svezia non lascia indifferente chi ha occhi e orecchie per intendere il calcio ben oltre l’angusto perimetro del mero intrattenimento. In particolare Fabio Bruno, animatore di Supertifo che in anni privi di social network rappresenta una vera e propria bibbia del tifo organizzato, fa da megafono a questi sentimenti raccontando nel suo Vita da ultrà le notti genovesi di quella estate e di fatto “santificando” nelle menti dei suoi numerosi lettori la tartan craze.
LEGGI ANCHE Scozia, il referendum per l’indipendenza: una lezione di democrazia
Negli anni successivi, quindi, la presenza negli stadi italiani di Saltire o striscioni riportanti denominazioni in un modo o nell’altro riconducibili all’alveo culturale o sportivo scozzese registra una vera e propria impennata sostituendo spesso quelle Union Jack esposte come sorta di tributo verso i pionieri del tifo. Una testimonianza dell’impatto dirompente avuto sull’immaginario dei ragazzi delle curve, sempre attenti a nuovi modi per declinare la bruciante passione per la propria squadra.
Tifosi scozzesi: patrioti indipendentisti
In virtù di questa sorta di shock culturale, nel corso degli anni si è quindi gradatamente consolidata nella mente della maggior parte dei frequentatori di stadi una immagine del tifoso scozzese fatta di bonomia, attitudine goliardica, passione smodata per l’alcol, incrollabile fede nella squadra e smisurato orgoglio patriottico nella stragrande maggioranza dei casi declinato in chiave anti-britannica e indipendentista.

Il tutto ovviamente impreziosito da kilt, tartan e cornamuse in quantità a conferire un tocco esotico che non guasta mai. Ma quanto di questa percezione così romantica corrisponde effettivamente alla realtà? La storia del seguito della Nazionale scozzese è, al contrario, tutt’altro che lineare e attraversa una serie di fasi ben definite che riflettono i mutamenti della società e che ne fanno un insieme alquanto eterogeneo e ricco di sfaccettature a volte in evidente contrasto tra loro.
Il tifoso che cambia
Il tifoso che in elegante completo si imbarca su un treno di linea verso Londra nel 1947 ha, quanto ad estetica e dinamiche comportamentali, poco o nulla a che spartire con l’adolescente scapestrato che invade il sacro manto di Wembley in anfibi e giacca in denim nel 1977. Il quale, a sua volta, è lontano anni luce dal tifoso middle class in full highland dress che raggiunge il Baltico alla fine degli anni Novanta. Cambia lo stile, cambia il modo di porsi e, soprattutto, cambia la percezione di cosa l’evento sportivo rappresenti.
LEGGI ANCHE Brexit, la Scozia vuole restare nell’Unione Europea
Nell’immediato dopoguerra la Nazionale è vista principalmente come una piacevole distrazione dalla routine del calcio di club e per questo gli appassionati spesso interpretano la presenza sugli spalti con leggerezza, al punto da non porsi troppi problemi nel fischiare sonoramente i giocatori delle squadre rivali che hanno la sventura di capitare a tiro.
Rivendicazione identitaria
Anzi, il fatto che per una serie di motivi il pubblico che affolla Hampden sia nella stragrande maggioranza costituito da tifosi dei Rangers fa sì che non di rado si generi una sorta di cortocircuito per il quale – al netto dell’orgoglio patriottico che porta comunque a sostenere la squadra nel suo complesso – i portacolori della metà biancoverde di Glasgow si trovano ad affrontare un clima tutt’altro che benevolo.
A partire dal Mondiale argentino del 1978, invece, l’atto di seguire la squadra viene interpretato sempre più di frequente come uno stile di vita totalizzante e incastonato in un perimetro culturale caratterizzato da una spiccata rivendicazione identitaria e da una altrettanto spiccata carica ribellistica di suo profondamente connaturata alla coeva società britannica.
Pellegrinaggi di massa a Wembley
L’esplosione delle sottoculture giovanili che caratterizza questo periodo non può non riverberarsi anche sulle gradinate degli stadi che, com’è noto, rimangono uno dei palcoscenici privilegiati in cui la working class esprime le sue dinamiche.
Per quanto sicuramente più legate al contesto del calcio di club, le tendenze conflittuali proprie dei filoni skinhead, boot boy o punk trovano sfogo anche in occasione dei biennali pellegrinaggi di massa a Wembley.
I barbari del nord
Chi è abituato alla glorificazione (a tratti melensa) che si fa della tartan army al giorno d’oggi trasalirebbe leggendo le cronache di quegli anni, quando centinaia di londinesi si barricavano in casa e chiudevano pub e negozi al passaggio dei “barbari del nord” e le compagnie di trasporto bandivano dai propri mezzi chiunque si mettesse in viaggio con una maglia da gioco e un accento troppo settentrionale.
Arrivano le donne
È solo con l’ultima decade del millennio – a partire da Italia ’90, appunto – che l’attuale prisma interpretativo inizia a divenire egemone esaltando la dimensione ludica e folklorica che pure, a scanso di equivoci, alla tifoseria non ha mai fatto difetto.
I cambiamenti sociali e culturali che caratterizzano il passaggio al nuovo millennio modificano inevitabilmente anche la composizione del seguito scozzese che annacqua via via la sua natura squisitamente working class per assumerne una decisamente più trasversale non solo in fatto di anagrafe e censo, ma anche di genere grazie all’arrivo sugli spalti di numeri crescenti di donne.
Via dai rivali inglesi
L’abbandono dell’angusta prospettiva dei tornei interbritannici a vantaggio dei nuovi viaggi oltre la Manica e la conseguente perdita della dimensione di sano antagonismo che caratterizza le sfide con i cugini contribuisce non poco a privilegiare un approccio assai più incentrato sulla pacifica condivisione dello spazio sportivo con la controparte.
Un modo efficacissimo, inoltre, per differenziarsi in maniera palese dai sempiterni rivali Inglesi che, nel medesimo periodo, attraversano il continente con attitudine assai diversa. Per la stampa e l’opinione pubblica questa diventa immediatamente l’unica chiave di lettura adottabile e ogni comportamento anche solo parzialmente divergente rispetto alla narrazione dominante viene messo in secondo piano.
Il tempio di Hampden Park
Fermarsi a questa semplicistica visione significa però non soltanto comprendere poco di quanto si muove attorno al “tempio” di Hampden Park, ma anche fraintendere grossolanamente la natura più intima della società scozzese che in non poche occasioni tende a rendersi palese proprio attraverso il calcio.
Andare oltre gli stereotipi, analizzare la storia di questa tifoseria e della sua evoluzione in termini attitudinali, comportamentali, estetici, politici e sociali e mettere in risalto le numerose linee di condotta che l’hanno caratterizzata negli anni consente invece di gettare uno sguardo scevro da contaminazioni sul più ampio contesto di cui questa è espressione.
Calcio e la distinta identità
In particolare consente di intersecare il tema dell’espressione di una distinta identità culturale all’interno del contesto britannico ed europeo che è tornata prepotentemente in auge dopo la Brexit e, in un’epoca come la nostra in cui l’imperante mercificazione e la stretta securitaria su ogni aspetto dell’esistenza stanno erodendo le dinamiche aggregative delle nostre comunità, permette di sottolineare una volta di più come il calcio sia stato e rimanga una delle dimensioni in cui si riflette in maniera più autentica l’anima di un popolo.